 Turismo
Turismo
A Trapani si costruivano barche con la vela latina
Trapani – C’era un tempo in cui a Trapani si viaggiava con il vento.
Non era solo un modo di dire, ma una realtà concreta, quotidiana, fatta di mani callose, legno di quercia, vele triangolari tese contro il cielo e il mare. Era il tempo delle barche a vela latina, quando il vento era il motore delle nostre rotte e l’intelligenza dell’uomo era arte.
Nel porto di Trapani, un tempo tra i più attivi del Mediterraneo, ormeggiavano buzzi, muciare, schifazzi, costruiti da maestri d’ascia che lavoravano nel silenzio interrotto solo dallo scroscio del mare. Erano barche nate per il lavoro: la pesca del tonno, del corallo, il trasporto del sale, della manna, della speranza.
La vela latina, con la sua forma semplice e potente, non era solo una vela: era una firma trapanese. Una vela che sapeva ascoltare il vento, piegarsi ad esso senza mai cedere, issarsi come bandiera di un popolo marinaro.
Ogni barca era unica, costruita a mano, senza piani scritti. Bastavano l’occhio, la memoria e la tradizione.
Diverse Famiglie come , da generazioni, trasformavano tavole grezze in scafi eleganti, capaci di reggere la tempesta e il tempo.
Dietro ogni chiodo, una preghiera.
Dietro ogni curva, un ricordo.
Chi saliva su una barca trapanese, sapeva di affidarsi a qualcosa di più di un semplice mezzo. Era una creatura viva, fatta di legno, sudore e anima.
Navigare con la vela latina era ascoltare il mare.
Non c’erano motori, né comandi elettronici. Solo il silenzio rotto dal fruscio del vento sulla vela, dallo scricchiolio delle tavole, dal richiamo dei gabbiani.
Si imparava a rispettare il mare e le sue regole.
Si partiva all’alba e si tornava al tramonto, con il sole in faccia e il sale sulla pelle.
Chi ricorda quei tempi, racconta con gli occhi lucidi la danza delle barche tra le correnti.
Era una danza lenta, fatta di gesti precisi e pazienti.
Una danza che oggi, in un mondo che corre, commuove.
Oggi, grazie all’impegno di appassionati e associazioni culturali, alcune di quelle barche sono tornate a solcare le acque.
Le regate storiche, i corsi di vela tradizionale, le uscite al largo con le vecchie vele issate: tutto questo è resistenza culturale.
È la memoria che non si arrende.
A Trapani, dove il mare è ancora parte del carattere della città, la vela latina è un filo che unisce passato e presente. Un simbolo silenzioso che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo.
Oggi i moli di Trapani sono cambiati, ma il vento è lo stesso.
Soffia tra le barche moderne, ma se ascolti bene, porta con sé la voce di chi navigava senza fretta, di chi conosceva ogni stella, ogni corrente.
Di chi costruiva con amore, e non per consumo.
E allora sì, forse dovremmo imparare di nuovo a viaggiare con il vento.
A fidarci della bellezza semplice, della fatica vera, del legame profondo tra l’uomo e la natura.
Perché una barca a vela latina non è solo un mezzo. È un insegnamento. È Trapani che respira.
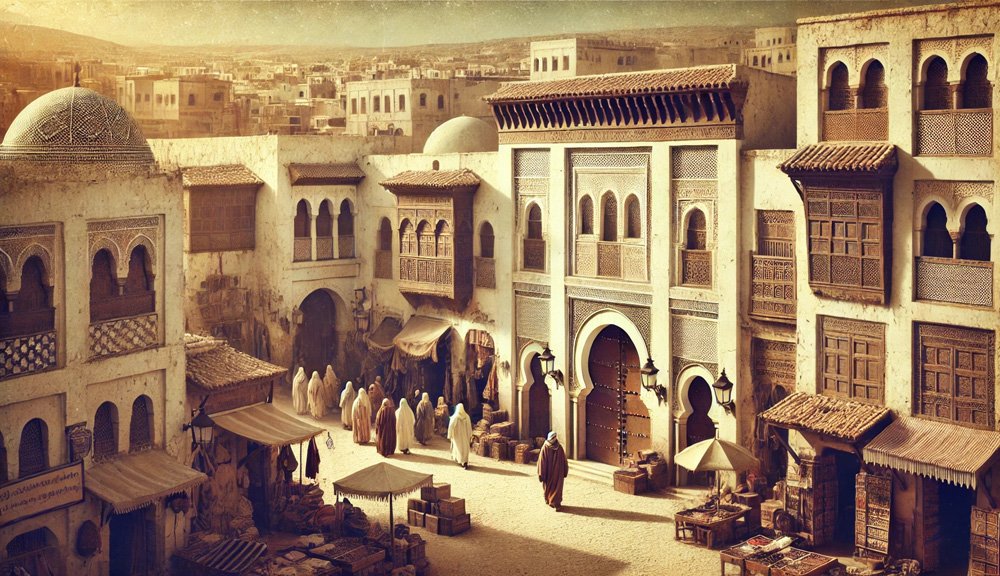 Altre Notizie
Altre Notizie
Il detto trapanese “A cu’ afferra un turco è so’” è un’espressione che, nel linguaggio moderno, significa che chi trova un oggetto può appropriarsene liberamente o, in senso più ampio, che ognuno è libero di fare ciò che vuole. Tuttavia, le origini storiche e il significato autentico di questo detto affondano le loro radici in un passato lontano, legato alla cultura marinara e agli eventi storici che segnarono Trapani nel XV e XVI secolo.
Nel contesto trapanese di quei secoli, il termine “turco” non indicava esclusivamente i cittadini dell’Impero Ottomano, ma era usato in senso dispregiativo per identificare tutti i popoli provenienti dall’Europa sudorientale, dal Medio Oriente e dal Nordafrica. La parola venne estesa anche a persone di carnagione scura, come i magrebini, a causa delle frequenti incursioni e del rapporto conflittuale con queste popolazioni.
Il detto nasce nel XVI secolo, un periodo in cui la pirateria imperversava nel Mediterraneo. All’epoca, molti stati europei rilasciavano ai comandanti delle navi una “patente di corsa”, un documento che autorizzava le navi a catturare i nemici considerati una minaccia, prendendoli prigionieri e riducendoli in schiavitù. I corsari erano quindi una sorta di pirati “legalizzati”, che dovevano però versare una tassa allo Stato sugli introiti ottenuti dalle loro attività.
Con l’aumento dei pericoli legati alla pirateria mediterranea, il viceré Colonna emanò una “prammatica” per incentivare la cattura dei pirati. Questo decreto esonerava i marinai trapanesi dal pagamento della tassa dovuta all’almirante (l’ammiraglio) per la cattura dei turchi. In altre parole, il ricavato della vendita degli schiavi catturati diventava **esentasse**, rendendo l’impresa più redditizia e incoraggiando le navi a correre i rischi della guerra di “Corsa”.
In questo contesto storico, il detto “A cu’ afferra un turco è so’” rifletteva una situazione molto concreta: chiunque riuscisse a catturare un “turco” (inteso come nemico) poteva considerarlo un proprio bottino, senza dover rendere conto alle autorità. Questo incentivo economico e giuridico rese l’attività corsara particolarmente attrattiva per i marinai dell’epoca.
Con il passare dei secoli, il detto perse il suo significato letterale legato alla pirateria e alla cattura dei nemici, trasformandosi in una metafora che celebra la libertà di appropriazione o di azione. Rimane, però, un’espressione carica di storia, che testimonia il ruolo di Trapani come crocevia di culture e teatro di conflitti nel Mediterraneo.
Il detto “A cu’ afferra un turco è so’” porta con sé una storia affascinante e complessa, ma siamo certi che ogni lettore potrebbe cogliere sfumature diverse o interpretazioni personali. Ti invitiamo a condividere i tuoi pensieri nei commenti!
Hai un punto di vista alternativo? Conosci altre storie legate a Trapani o ai proverbi della tradizione siciliana? Oppure, magari, il detto ti ricorda un’esperienza personale? Lasciaci un tuo contributo! Ogni voce arricchisce questa narrazione e ci permette di scoprire nuove prospettive. Facci sapere cosa ne pensi!